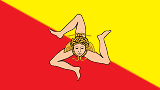Il quarto capitolo del libro di Franco Busalacchi
“Se ne va! Parte, capisci, parte! Alla buon’ora!”. Antonia non poteva né voleva nascondere la sua corriva allegria. Quasi danzava attorno a Geppa la timida, la timorosa, la tremebonda. Mentre Antonia turbinava, Geppa, senza riuscirci, tentava di dare forme concrete e sensibili ai suoi contrastanti sentimenti. Gustava sì quella leggera e gradevole sensazione che pure lei aveva sentito nascere dentro di sé alla notizia della partenza di Eugenia ma nello stesso tempo provava una sottile, sotterranea inquietudine.
“Resteremo sole, tu, la mamma e io?” C’era tutto in questa domanda quasi sussurrata, la fatua speranza di una esistenza nuova tutta da vivere, in mezzo a persone divertenti, allegre, di mondo, e la consapevolezza che, lei, proprio lei che si sapeva debole e priva di carattere, sarebbe passata dal governo forte ma invasivo, opprimente ma pure rassicurante di sua sorella Eugenia, all’influenza della coinvolgente, vana e forse pericolosa, almeno lei lo intuiva confusamente, Antonia, l’altra sua sorella.
“Sole? Ma no, che dici! La solitudine è finita, sorellina!”, era stata la risposta beffarda di Antonia.
Eugenia si alzò dal banco, si segnò e uscì dalla cappella. Discese i gradini e si immise nel lungo viale centrale dell’Istituto su cui si affacciavano i padiglioni di degenza, distinti per sesso, età e patologie. Si guardò intorno. Era un luogo di dolore, quello, lei lo sapeva bene, un luogo dal quale la speranza era quasi bandita, dove la scienza ancora balbettava e in forza di leggi inadeguate, figlie di condizioni sociali ingiuste cui solo la pietà cercava di porre rimedio, si trovavano a convivere i frutti di grandi atti di misericordia e di disumane sopraffazioni. Un luogo con il quale, così come con altre istituzioni quali le carceri e i cimiteri, il consorzio umano, non riuscendo a fronteggiare in se stesso il male che le originava, quasi ne accettava l’ineluttabilità. Si condannava così a conviverci, a tenerle nelle cerchia delle sue città, confinandole quindi nella normalità.
A passi lenti, seguitando a volgere ogni tanto uno sguardo sugli ampi spazi verdi che separavano i padiglioni, quasi ad imprimere nella memoria quanti più particolari le fosse possibile, si diresse verso l’uscita. Passò davanti al grande edificio dove aveva sede l’amministrazione, una massiccia ed incombente costruzione in greve stile umbertino, adiacente al quale era collocato il cancello di ingresso dell’Istituto.
Gli attimi di raccoglimento e la preghiera fervida che aveva recitato davanti alla statuetta della dolce, sognante Madonnina di cartapesta dal manto stellato attorno alla quale era raccolta la piccola cappella dell’ospedale, non l’avevano pacificata. Era in balìa di sentimenti contrastanti nei quali, invano, camminando svogliatamente cercava di mettere ordine. Una cosa era certa: anche se non ancora fisicamente, aveva già lasciato la Vignicella, l’Istituto psichiatrico diretto da Sperio nel quale aveva fino ad allora prestato servizio di internato. Si era già accomiatata dai medici del suo reparto che le avevano manifestato il loro rammarico. Sentitamente, è vero, ma con espressioni forse un po’ esagerate che l’avevano piuttosto confusa e nelle quali le era parso di cogliere una reazione alla decisione del direttore che avevano dovuto subire.
Si era poi a lungo trattenuta con le colleghe, le più avvedute, le quali mostrarono un dispiacere che ad Eugenia parve sincero. Eppure, anche se veritiero, quel dispiacere era anch’esso egoistico: quelle brave donne avevano tutte avuto subito chiaro quale appoggio e quanta sicurezza sarebbero loro venuti meno.
Quando Sperio, a cui nel tempo e a mezze frasi aveva confidato certi suoi disagi e certe sue intenzioni, le aveva prospettato di trasferirsi a Granfonte, una cittadina alle pendici dell’Etna, per assistere in casa la moglie di un suo vecchio e caro amico malata di mente, non aveva avuto molte esitazioni. Questo non perché non avesse mai avuto intenzione di stabilizzarsi in un nosocomio, né per il pur cospicuo compenso che lo stesso Sperio le aveva fatto intravedere e che pure la lusingava; a farla decidere era stata la stanchezza.
Aveva già trent’anni, forse, come aveva pensato tante volte tra sé, aveva avuto sempre trent’anni, e questo ora lo sentiva come una condanna certa, specialmente dopo la morte del padre che dall’agiatezza aveva costretto la sua famiglia ad una modesta esistenza.
Successivamente alla morte della prima moglie, la madre di Eugenia, l’ormai stagionato Agostino Ruta, titolare dell’omonima ditta, non aveva deposto le armi, anzi. Ancora in forze, piacente, benestante, non aveva tardato a fare breccia nel fragile cuore della madre di Rosetta Baio che non ebbe difficoltà a convincere la figlia, già abbagliata di suo da una carrozza, due cavalli e un anellino. Le mutate condizioni economiche avevano inciso in modo diversissimo sulle tre figlie. In Eugenia si era ulteriormente accentuato il senso di responsabilità ma non la disponibilità a sopportarne il fardello. In Antonia, la prepotente, superficiale voglia di vivere aveva precluso ogni possibilità di accettazione di uno stato che a quell’istinto negava i mezzi di soddisfazione. In Geppa, infine, la conclamata precarietà materiale aveva accentuato le innate insicurezze affettive e il bisogno di appoggiarsi perennemente ad altri. Bisogno che si rivela sempre pericoloso se insieme ad esso non si possiedono le capacità di giudicare se l’appoggio al quale ci affidiamo, oltre che valido, è anche disinteressato. Se le avesse lasciate libere nei loro impulsi, rifletteva Eugenia, la loro madre, superficiale e poco perspicace e le sorelle, molto più giovani di lei, poco più che adolescenti e incontrollate nella loro vana sconsideratezza, che cosa sarebbe successo? Presto la condizione modesta ma dignitosa che l’oculata gestione da parte sua dei pochi beni rimasti consentiva loro sarebbe digradata verso una vera e propria indigenza. Le sue sorelle, la più giovane specialmente, mordevano freno.
Antonia non voleva credere affatto che dopo la morte improvvisa del padre fosse necessario ridimensionare il loro tenore di vita. Non voleva capire che il loro benessere, la loro posizione, era stata frutto quasi esclusivamente dell’attività personale dell’uomo e non si fondava su un suo patrimonio, né che, morto lui, le entrate di famiglia si erano drasticamente ridotte. Attribuiva all’avarizia della sorellastra, ad Eugenia, dura e severa, la loro vita appartata e la modestia delle loro rarefatte relazioni. La detestava e tempestava la madre, alla quale rimproverava la svaporatezza, sostenendo che questa, e non altro, era la causa della loro sudditanza alla sorella. Eugenia, la vita, almeno quella che comunemente si intende per vita, l’aveva solo sfiorata. Sentiva che si stava illividendo sotto il peso sempre crescente delle responsabilità che assumeva su di sé e che gli altri, proprio perché inconsapevoli, le imponevano. Le sue sorelle, troppo diverse da lei e che col tempo le stavano diventando nemiche e lei, che lo sentiva, aveva cominciato a ricambiare, diventando sempre più dura ed intransigente. Stava sbagliando, ne era consapevole, ma era stanca.
Aveva sempre saputo di essere migliore delle sorelle, ed esse avvertivano ancora più chiaramente di lei la loro reciproca diversità, così tra loro era cominciato un lento, irreversibile distacco e le giovani avevano avuto buon giuoco nel portare dalla loro parte la madre. Il lavoro aveva condotto a poco a poco Eugenia verso una sorta di liberazione affettiva che accentuava sempre più, mettendola a nudo, la distanza spirituale che la separava dalla sua famiglia il cui sentimento di inferiorità e la cui dipendenza psicologica, aggravati dalle ragioni di necessità addotte da Eugenia, ma che non le convincevano, imponevano loro di condurre un’esistenza molto più appartata e schiva di quella che,seguendo la propria indole, si sentivano in diritto di vivere. Ben venga dunque questa opportunità, aveva concluso, forse staremo meglio tutti.
Alla stazione i saluti che Rosetta e le sorelle si erano scambiati a casa con sorvegliata profusione di effetti e ipocrisia furono rinnovati con ancora meno calore ed intensità e la loro pubblica manifestazione fece emergere nella sua triste profondità la nuda radice e la vera natura dei loro sentimenti .All’abbraccio di Eugenia, Rosetta rispose con due baci sulle guance della figliastra, rituali e leziosi. La piccola Geppa pianse con puntualità, ma era sincera nel suo piccolo dolore che pure sapeva passeggero. Lo sguardo che Antonia ed Eugenia si scambiarono non riguardò il loro presente, né il passato. In quello come in tutto il resto, non avevano nulla in comune, nulla da condividere e ricordare insieme, nulla che conservasse una pur minima traccia di reciproca partecipazione. Per un istante, però, entrambe ebbero la consapevolezza che un giorno si sarebbero rincontrate, che avrebbero lottato per qualcosa, ancora una volta con sentimenti e obbiettivi opposti. Eugenia ne rabbrividì.
AVVISO AI NOSTRI LETTORI
Se ti è piaciuto questo articolo e ritieni il sito d'informazione InuoviVespri.it interessante, se vuoi puoi anche sostenerlo con una donazione. I InuoviVespri.it è un sito d'informazione indipendente che risponde soltato ai giornalisti che lo gestiscono. La nostra unica forza sta nei lettori che ci seguono e, possibilmente, che ci sostengono con il loro libero contributo.-La redazione
Effettua una donazione con paypal