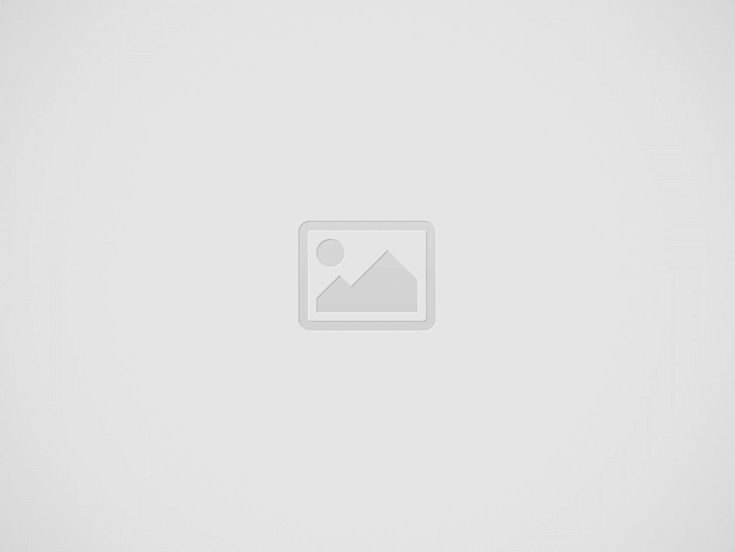

Nella seduta parlamentare del 29 aprile 1862, quindi più di un anno prima della Legge Pica, il deputato Giuseppe Ferrari affermava: «Non potete negare che intere famiglie vengono arrestate senza il minimo pretesto; che vi sono, in quelle province, degli uomini assolti dai giudici e che sono ancora in carcere. Si è introdotta una nuova legge in base alla quale ogni uomo preso con le armi in pugno viene fucilato. Questa si chiama guerra barbarica, guerra senza quartiere. Se la vostra coscienza non vi dice che state sguazzando nel sangue, non so più come esprimermi» (Patrick Keyes O’Clery, La rivoluzione italiana. Come fu fatta l’Unità della nazione). Questo è lo squallido scenario di violenza e arbitrio cui la Legge Pica intendeva conferire una parvenza di legittimazione. Ma per fare ciò gli esaltatori delle Costituzioni, i garantisti pronti a stracciarsi le vesti di fronte a ogni timido tentativo di autodifesa degli stati di antico regime, gli esagitati difensori della libertà di pensiero e di espressione non esitarono a calpestare lo stesso Statuto albertino. Il primo pilastro della Carta ad essere abbattuto fu il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 24 («Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi»). Poi il principio del giudice naturale, espresso dall’art. 71 («Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie»). Inutile aggiungere quale spazio potesse trovare il diritto di difesa dell’imputato, affidato a un ufficiale dell’esercito d’occupazione.
La feroce disciplina penale introdotta dalla Legge Pica poteva, inoltre, essere estesa ad altre province con un semplice decreto reale, privando, quindi, il Parlamento della potestà legislativa in una materia così scottante, in violazione dell’art. 3 («Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati»). Oltretutto, la genericità della previsione normativa metteva ancor più l’imputato alla mercé dell’accusa. Ciò era particolarmente grave ed evidente con riferimento al concorso nel reato da parte di terzi estranei all’associazione, dato che, secondo l’art. 2 della Legge, «ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti di ogni maniera, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita», laddove l’espressione “aiuti di ogni maniera” lascia del tutto indeterminata la fattispecie criminosa, consentendo di comprendervi finanche la mera propaganda o il semplice sostegno verbale. Attraverso note e circolari ministeriali, poi, il potere esecutivo si arrogava il compito di risolvere i dubbi interpretativi, incidendo arbitrariamente sulla libertà delle persone. Un colpo di maglio particolarmente odioso ad ogni elementare principio di civiltà giuridica è, poi, assestato dalla disciplina del domicilio coatto, pesante misura che viene irrogata sulla base del semplice inserimento in una lista di sospetti, compilata da Commissioni provinciali: «Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, a’ vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, non che ai camorristi, e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di due Consiglieri Provinciali». Mediante questa norma infame, giustamente denunciata con accenti di vibrante indignazione da Inorch Scorangef, si sottomette la giustizia all’interesse privato, consentendo alle denunce anche anonime, ispirate da ogni sorta di motivazione, di portare alla privazione della libertà del sospettato; i cui beni, oltretutto, dopo la sottoposizione a domicilio coatto, rimanevano in balia di nemici personali, approfittatori, ladri e sciacalli di ogni risma, a cominciare dai galantuomini che la facevano da padrone nei comuni e che furiosamente premevano affinché i loro antagonisti sociali, ossia i contadini, fossero privati dei loro diritti e resi inoffensivi, magari attraverso l’eliminazione fisica.
Né va trascurato che il Regolamento della Legge Pica prevedeva la possibilità di assoldare squadre di uomini a piedi o a cavallo offertesi volontariamente per la repressione del brigantaggio. Facile immaginare come i possidenti e gli usurai più esposti alla pubblica indignazione siano stati spinti a costituire formazioni di mercenari al fine di tutelare la loro impunità e di eliminare chi si opponeva alla loro prepotenza e ai loro soprusi. È evidente come tale situazione abbia inasprito fino all’inverosimile gli odi nelle campagne, rappresentando la concreta dimostrazione di come il potere degli invasori fosse a disposizione dei ceti parassitari per consentire loro di regolare i conti in sospeso con chi voleva solo vivere onestamente del proprio lavoro. Se a ciò si aggiunge il fenomeno, pure incentivato dalle autorità piemontesi, dei cacciatori di taglie, il quadro è abbastanza completo e ha colori che non è esagerato definire infernali.
Edoardo Vitale “La barbarie mascherata da legalità” da ALTA TERRA DI LAVORO
Tratto da Regno delle Due Sicilie.eu
Foto tratta da Il Mattino