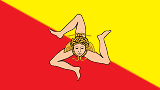La politica alfonsina in Sicilia
Perché il titolo di Rex utriusque Siciliae non significa “delle Due Sicilie” ma “dei due Regni di Sicilia”
Il Viceregno si consolida
L’Unione “perpetua” con l’Aragona deliberata da Re Giovanni e le sue conseguenze
…Ma il Parlamento si prende tutto il potere legislativo e la politica tributaria
Un Viceré assai costituzionale…
In Sicilia nasce la statistica…
Di fatto una “repubblica aristocratica” semi-indipendente
Perché nel complesso questo rallentò lo sviluppo della Sicilia come Nazione
Palermo ridiventa capitale anche di fatto, sebbene un po’ contrastata
di Massimo Costa
La politica alfonsina in Sicilia
Alfonso per qualche anno si stabilì in Sicilia (1421 e 1432-35), dove riorganizzò il regno, con una politica accorta di concessioni e restrizioni, sempre all’insegna di una grande intelligenza politica. Nel 1433 presiedette egli stesso il Parlamento, senza l’intermediazione viceregia. Durante il suo soggiorno in Sicilia fondamentalmente ne fece base per il suo grande disegno, la conquista del traballante Regno di Napoli e infatti istituì una curiosa carica nella vacanza di quella viceregia, che in sua presenza non avrebbe avuto molto senso: i “Presidenti del Regno”. Questi gestivano appena l’ordinaria amministrazione, dovendosi rivolgere a lui per ogni altra cosa e non potendo neanche convocare il Parlamento. Ma erano necessari giacché, anche quando presente in Sicilia, non poteva essere sua principale preoccupazione l’amministrazione della Sicilia, che era solo uno dei tanti regni, e per di più nel corso di operazioni militari. Dopo di ciò questa carica sarà usata anche per tamponare brevi vacanze nell’ufficio del viceré, su indicazione dello stesso che designava un “presidente” come sostituto, quasi sempre l’arcivescovo di Palermo. In caso di morte improvvisa o di sostituzione senza aver nominato il sostituto, assumeva invece la presidenza del Regno il Gran Giustiziere, assistito dal Sacro Regio Consiglio, come era nella prassi costituzionale dello Stato sin dai più antichi tempi. Durante la sua permanenza in Sicilia dotò l’Isola della sua prima università: l’Università degli Studi di Catania (del 1440 la bolla papale), quel “Siculorum Gymnasium” da cui sarebbero usciti i laureati in legge necessari per la giustizia e per la burocrazia dello Stato, imprimendo così una svolta innovativa alle strutture ancora medievali della vecchia amministrazione. L’Università fu dotata anche della Facoltà di Medicina, per emanciparsi dalla più lontana Salerno. Tra le innovazioni del re i “Capitoli del Protomedicato”, con cui si riorganizzavano gli uffici sanitari (1429); all’invenzione della stampa questi capitoli sarebbero stati pubblicati da uno dei più noti protomedici del Regno, lo studioso di veterinaria Gian Filippo Ingrassia, nel 1504. Il protomedico rilasciava le licenze per l’esercizio della professione medica, sovrintendeva alla salute nel Regno, autorizzava gli uffici di “salassatore” (una sorta di infermiere), levatrice, aromatario (farmacista). Altra importante riforma, fu la riorganizzazione di tutta la procedura, civile e criminale (1446), con Capitoli che sarebbero arrivati praticamente alle soglie dell’Età contemporanea. Favorì molto i commercianti italiani in Sicilia, specie i pisani, più che gli autoctoni, segnando involontariamente una divisione del lavoro in cui all’Isola toccava soprattutto il settore primario, peraltro allora importantissimo. Alfonso trovò il tempo di riprendere la politica “africana” del Regno di Sicilia, esercitando pressioni e organizzando spedizioni sul vicino regno di Tunisi. Questa politica, però, continuata peraltro dai suoi successori, si rivelò ben povera di frutti, in termini di conquiste stabili, anche perché ormai il Mediterraneo era segnato da una presenza ottomana, e islamica in generale, sempre più soverchiante. Non dimentichiamo che proprio sotto la sua monarchia si ebbe la storica caduta di Costantinopoli in mano turca. Non mancarono tregue o altri tipi di attività diplomatiche, gestite direttamente dai viceré, come quella con Tunisi del 1438.
Perché il titolo di Rex utriusque Siciliae non significa “delle Due Sicilie” ma “dei due Regni di Sicilia”
Nel 1430 la quieta Sicilia ha un sussulto indipendentista. Il figlio naturale di re Martino, Federico de Luna, appoggia la Castiglia contro l’Aragona, e trova alcuni sostegni nella feudalità siciliana di origine “latina” che non aveva ancora del tutto rinunciato ad avere un proprio re. L’azione di Federico fu sventata, e finì i suoi giorni emarginato, senza dare peraltro discendenza stabile all’ultima casa regnante propria di Sicilia. Nel 1442 – come abbiamo detto – Alfonso entrò in Napoli, ma non per questo fu stravolto il Trattato concluso nel 1372 tra i due regni. Fino ad allora il Regno di Sicilia, nella sola corrispondenza con il Papa, doveva ancora usare il titolo umiliante di “Re di Trinacria”. Da questo momento in poi Alfonso legittima, per entrambi i Regni, l’uso del termine “Re di Sicilia”, ma poiché la Sicilia vera era quella insulare, il Regno di Sicilia “al di qua del Faro” (la Sicilia propria teoricamente ora era “Regno di Sicilia al di là del Faro”) cominciò ufficiosamente anche ad essere chiamato “Regno di Napoli”, anche in via amministrativa. Per giustificare questa dualità, prese il titolo di “Rex utriusque Siciliae” (cioè Re di entrambe le Sicilie, ovvero dei due regni distinti). Falso storico, quindi, che Alfonso abbia creato il “Regno delle Due Sicilie”, mentre è vero proprio il contrario, e cioè che Alfonso mantenne, anzi istituì, la dualità delle corone e degli stati, solo incidentalmente riuniti sotto la sua persona. La Sicilia non guadagnò moltissimo da questa conquista, a dire il vero. Alfonso, infatti, pose a Napoli la sua reggia, da cui controllava il suo impero Mediterraneo, e come abbiamo visto entrò nel gioco degli stati italiani e si comportò come vero sovrano italiano, facendo di Napoli una grande capitale dell’Umanesimo. Non restituì alla Sicilia nemmeno le Isole Eolie, retrocesse nel trattato del 1372 a Napoli, e forse fu tanto se il Regno di Sicilia mantenne nome e stato, con tanto di istituzioni parlamentari, mentre a Napoli Alfonso poteva tranquillamente governare in modo assoluto. In Sicilia continuavano ad essere inviati viceré, ma Alfonso da Napoli continuò ad occuparsi in prima persona anche degli affari del regno insulare. A Napoli la cancelleria alfonsina scelse di affiancare al latino per la prima volta il volgare toscano nel quadro della politica italiana del sovrano. In Sicilia, che già dal secolo precedente aveva adottato il siciliano come lingua propria, invece non cambiò nulla, anche se una certa influenza dell’italiano cancelleresco sul siciliano quattrocentesco è innegabile. Da notare che nel 1443 ottenne dal papa l’investitura di Napoli, come feudo pontificio, mentre la Sicilia non solo restò del tutto indipendente, ma vide esercitare con nuovo vigore la piena autonomia ecclesiastica garantita dall’apostolica legazìa. Anche i riti religiosi erano diversi tra Napoli e Sicilia (a parte i bizantini uniati, diffusi tanto in Calabria quanto nel Val Demone): a Napoli il messale era quello romano, in Sicilia era quello gallicano, già introdotto dai Normanni secoli prima alla loro venuta (e tale differenza sarebbe rimasta sino al Concilio di Trento, nel XVI secolo).
Il Viceregno si consolida
Il Parlamento del 1446 introduce per la prima volta un donativo specifico per il viceré, oltre a quello ormai comune per il re, cioè per lo Stato. La Sicilia alfonsina sembrava in superficie pacificata, con un buon equilibrio di poteri tra Corona e Parlamento, tra Città e Feudi, con un rinnovato vigore della legge e senza più alcun rigurgito di quell’anarchia feudale che aveva rovinato il regno indipendente un secolo prima. Ma la malapianta doveva essere ancora piuttosto forte nella Sicilia profonda. E così sarebbe rimasta almeno per tutto il secolo. Significativi in tal senso i primi “Fatti di Sciacca” del 1455, consistenti in una vera e propria faida tra le famiglie dei Perollo e dei De Luna. Dovette intervenire il re, con la confisca dei beni e il bando per i responsabili, per riportare almeno una parvenza di ordine. Così pure non fu facilissima la vita dei viceré, spesso rimossi non perché non avevano tutelato gli interessi del Regno (non mancavano atti di vero e proprio servilismo verso l’Aragona infatti), ma perché avevano toccato qualche privilegio baronale. Ma, almeno fino a che fu re Alfonso, la presenza del re si faceva sentire a riequilibrare queste spinte anarchiche. Negli ultimi anni non cambio più viceré, lasciando sempre l’abile e fidato Lopes ovvero Lupo Ximenes de Urrea, il quale, un po’ perché uomo politico di prim’ordine nella monarchia alfonsina, un po’ perché richiamato a Napoli per ricevere disposizioni, si servì più volte, per l’ordinaria amministrazione, di “Presidenti del Regno” lasciati in sua vece nelle brevi assenze.
L’Unione “perpetua” con l’Aragona deliberata da Re Giovanni e le sue conseguenze
Alla sua morte, nel 1458, i due Regni di Sicilia presero nuovamente a dividersi: Napoli fu lasciata al figlio naturale Ferdinando; tutte le altre corone, Sicilia inclusa, al fratello Giovanni, colui che in gioventù era stato vicario in Sicilia, e che già da tempo era suo vicario a Barcellona. Il Parlamento di Sicilia chiede subito a Giovanni che Carlo, figlio di primo letto del re e di Bianca di Navarra, fosse nominato vicario per la Sicilia, e che per il futuro i viceré dovessero essere sempre i primogeniti dei sovrani. La presenza vicina di Alfonso aveva fatto rinviare la richiesta del re proprio, ma il rapporto tra Aragona e Sicilia era rimasto ancora piuttosto confuso, quasi da semplice unione personale delle corone. Giovanni, conoscendo bene e personalmente le non sopite aspirazione nazionali dei Siciliani, ebbe paura di questa richiesta, temendo che il figlio, al quale naturalmente spettava la Navarra ereditata dalla madre Bianca, non finisse per essere acclamato re di Sicilia, e pensò di sistemare una volta e per tutte la Questione Siciliana. Per sciogliere questa contraddizione operò una riforma costituzionale, nel 1460. Fu proclamata l’Unione Perpetua tra le corone di Aragona e Sicilia, in pratica la perdita dell’indipendenza esterna dello Stato di Sicilia, sino ad allora unito sì all’Aragona, ma teoricamente in unione personale reversibile. Non doveva essere però poi così sicuro re Giovanni di questa unione se, già nel 1464, chiese al Parlamento siciliano di riconoscere come erede al trono il figlio Ferdinando, avuto dal suo secondo matrimonio.
…Ma il Parlamento si prende tutto il potere legislativo e la politica tributaria
A questa riforma aggiunse la figura del “Viceré proprietario”: non più siciliano, nominato stabilmente con un mandato di tre anni (in teoria, quanto prese a durare la legislazione parlamentare, ormai più regolare, ma spesso prorogato), dotato di tutti i poteri del re. In pratica da questo momento in poi i sovrani si disinteressano delle vicende interne dello Stato siciliano. E questi provvedimenti servivano per tenere la Sicilia “eternamente” unita all’Aragona. Per contro, però, al suo interno, lo Stato di Sicilia è lasciato nella più piena indipendenza. Il Parlamento sarebbe stato convocato con regolarità ogni tre anni, stabilmente formato da tre Camere o Bracci: Militare, in rappresentanza dei feudi laici, Ecclesiastico, in rappresentanza dei feudi ecclesiastici (abbazie) e dell’episcopato, e Demaniale, in rappresentanza dei liberi comuni o città demaniali, cioè i 42 centri più importanti del Regno. Tra una convocazione e l’altra, il Parlamento siede in permanenza per mezzo di una Deputazione del Regno di 12 componenti (4 per ogni Braccio), alla quale è delegata tutta la riscossione delle imposte dirette (sottratta al Governo Viceregio, che può amministrare direttamente solo quelle indirette, o gabelle). Più correttamente va detto che sotto Giovanni si cristallizzano prassi che si erano andate via via formando sotto il regno del fratello, come appunto quella della Deputazione. Le imposte dirette, introdotte come strumento di finanza straordinaria sotto i re normanni e svevi (da cui il nome storico di “donativi” per esigenze speciali del Regno che assunsero ora al posto delle vecchie “collette”), diventarono la norma nel periodo della dinastia Aragona, e, poco a poco, sarebbero diventate la fonte più importante della finanza statale, oltre alle vecchie gabelle che, per motivi ideologici, il Vespro aveva dovuto ridurre a quelle “antiche” (cioè vigenti ai tempi di Guglielmo il Buono, abrogando quelle istituite da Federico Imperatore). Col tempo il Parlamento di Sicilia avrebbe votato senza condizioni il donativo ordinario, teoricamente sempre un “dono” e quindi per questo votato dal Parlamento, mentre quello straordinario era oggetto di una vera e propria trattativa con la Corona, in cambio del placet regio sui Capitoli (cioè leggi) votati dal Parlamento. Non a caso le leggi capitolari erano chiamate “pactatae”, cioè concordate tra Re e Parlamento.
Un Viceré assai costituzionale…
In tal modo il Parlamento di Sicilia esercitava già, in maniera assai precoce, le funzioni finanziarie e legislative tipiche dei moderni parlamenti. Tutte le magistrature del regno, civili, penali, ecclesiastiche, amministrative, contabili, rigorosamente riservate a regnicoli, con incarichi lunghi, quando non a vita. I più importanti dei quali sono dati dal Sacro Regio Consiglio che attornia (o condiziona?) il Viceré nelle decisioni di ogni giorno. La legislazione diventa ormai stabilmente “capitolare”, cioè votata dal Parlamento, con il placet regio, ad ogni richiesta triennale di donativi, ma le antiche “Costituzioni” (votate dai Parlamenti su proposta regia) non perdono vigore, anzi costituiscono il cuore del diritto siculo, insieme all’eterno diritto romano come base del diritto civile. Al di sotto di queste leggi troviamo le prammatiche, regie e viceregie, o i dispacci regi. Ma questa legislazione, di secondo livello, è pure soggetta a sindacato di legittimità da parte delle magistrature del Regno. Il Viceré non può emettere prammatiche in contrapposizione alle leggi capitolari votate dai Parlamenti. Il Re invece può, ma queste sono soggette comunque a un sindacato di costituzionalità da parte della Magna Curia dei Maestri Razionali, che ha il potere di dare “esecutoria” (cioè efficacia) nel Regno per ogni atto del Re. La cittadinanza, infine, può essere attribuita a forestieri solo dal Parlamento, e spesso questo privilegio era ad esempio accordato ai viceré che intendevano naturalizzarsi per mezzo di matrimoni o acquisto di feudi in Sicilia.
In Sicilia nasce la statistica…
Lo sviluppo precoce di una finanza parlamentare comporta la necessità di distribuire il donativo in base grosso modo alla capacità contributiva, e quindi si porta dietro l’esigenza di sviluppare veri e propri censimenti. La Sicilia, in questo, ha un vero e proprio primato, con censimenti, a fini fiscali/feudali che datano dallo sbarco normanno, quando già erano comuni le “platee”, cioè le descrizioni delle terre con gli abitanti, in particolare i villani, che sulle stesse insistono. Nei secoli questa tecnica si affina sempre più e trova impulso formidabile nel meccanismo finanziario dei donativi parlamentari. Sta di fatto che, già dal 1501, la Sicilia ha il suo primo censimento generale, seguito dal secondo nel 1548, e poi via via nel tempo in maniera sempre più frequente, sviluppando una vera e propria tradizione statistica nazionale.
Di fatto una “repubblica aristocratica” semi-indipendente
La Sicilia ha anche moneta propria, coniata dalla zecca di Messina, flotta propria, è insomma un vero stato a sé. Di norma non un centesimo di tributi siciliani va all’Aragona, se non per qualche ben specifica esigenza militare, votata dal Parlamento, non una legge catalana si applica in Sicilia, non un ufficio (al di fuori di quello di viceré) poteva essere affidato a chi siciliano non era. Naturalmente non mancavano eccezioni a questa totale indipendenza fiscale, trattate però di volta in volta in quanto tali, come quando re Giovanni chiese esplicitamente alla Sicilia denaro per domare una rivolta in Catalogna aizzata dal re di Francia o, più tardi, quando la Sicilia mandò truppe per sedare gli ultimi conati indipendentistici della Sardegna del Marchese di Oristano. In una parola, per garantirsi la fedeltà del Regno in politica estera, Giovanni stava letteralmente regalando lo Stato di Sicilia ai baroni, trasformandolo di fatto in una sorta di repubblica baronale, con la partecipazione subalterna delle oligarchie “borgesi” dei principali centri urbani. Ciò, nel lungo termine, avrebbe risparmiato alla Sicilia ogni forma di sfruttamento esterno coloniale. La mancanza di politica estera propria avrebbe favorito un periodo lungo di sostanziale pace (magari mentre il re combatteva guerre lontane, chiedendo qualche aiuto alle milizie baronali del Regno), e quindi una crescita economica sostanziale, una crescita demografica che avrebbe inaugurato un periodo di colonizzazione interna e di creazione di nuovi insediamenti, tutti feudali.
Perché nel complesso questo rallentò lo sviluppo della Sicilia come Nazione
Per contro, però, la mancanza di un vero re e di una vera corte propria (il viceré restava sempre una figura assai debole), impediva la tutela nel lungo termine di un interesse nazionale, favoriva il particolarismo municipale, ostacolava l’innovazione (a parte poche grandi riforme promosse direttamente dalla Corona), e avrebbe favorito, sui lunghi tempi, l’immobilismo nei privilegi.
Palermo ridiventa capitale anche di fatto, sebbene un po’ contrastata
Il viceré, già dall’invio dei primi vicegerenti da parte di Ferdinando I, prese a risiedere sempre più spesso a Palermo, dopo il relativo declino dell’epoca indipendente, quando i Chiaramonte avevano quasi cacciato i re dalla capitale, e proprio nel loro Palazzo, lo Steri, mentre il Palazzo reale era un po’ decaduto. Dall’epoca di re Giovanni questo primato si fa praticamente irreversibile, ma il viceré non manca mai di girare il Regno e, per assecondare un po’ il municipalismo delle altre due con-capitali, risiedeva per alcun tempo a Messina, e più raramente a Catania. Municipalismo che non viene mai del tutto stroncato dalla corona iberica, che doveva conoscere bene il motto romano del divide et impera.
Foto tratta da Historia Regni
AVVISO AI NOSTRI LETTORI
Se ti è piaciuto questo articolo e ritieni il sito d'informazione InuoviVespri.it interessante, se vuoi puoi anche sostenerlo con una donazione. I InuoviVespri.it è un sito d'informazione indipendente che risponde soltato ai giornalisti che lo gestiscono. La nostra unica forza sta nei lettori che ci seguono e, possibilmente, che ci sostengono con il loro libero contributo.-La redazione
Effettua una donazione con paypal