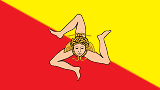Continua la pubblicazione online del romanzo a puntate di Franco Busalacchi
il sesto capitolo qui
Cercò di allontanare i pensieri e di riposare. Era sola nella vettura e non le fu difficile entrare in sintonia con il passo del convoglio e farsi cullare dal dondolio del vagone. L’aspettava un lungo viaggio. Non aveva mai viaggiato così a lungo in treno, solo brevi spostamenti, per raggiungere vicine località estive dove le ricoverate in condizioni di essere trasportate passavano qualche giorno.
Il treno si era bruscamente allontanato dalla costa e nel suo percorso si andava dirigendo verso l’interno, seguendo il fondo di una lunga valle verso sud-est, incontro ad un sole ancora basso. Un corto tappeto verde ricopriva il terreno collinoso in cui si alternavano piccoli dossi e lunghi valloncelli che finivano a ridosso dello sterrato e le cui acque venivano inghiottite dalle caditoie poste sotto la strada ferrata. Alle pendici e sui dorsi del massiccio montuoso che si avvicinava, alto e possente, erano aggrappati paesini, borghi e casaleni solitari. Dallo spiraglio di un finestrino del corridoio davanti al suo scompartimento, Eugenia respirava un’aria sottile, fresca e profumata di quel profumo che dall’erba umida risale lieve lieve e che si perde in un attimo, volando via, respinto dalla nostra assuefazione. C’erano goccioline d’acqua sul vetro, notò, che si rompevano e scendevano lungo il finestrino, rigandolo in una fitta trama, per una strana associazione la resero più attenta al paesaggio. Guardò fuori, in basso, e scoprì il fiume, il cui corso in quel tratto stava fiancheggiando la strada ferrata. Un fiume, sì, non un torrente, non uno di quei tanti fiumiciattoli che con la stagione calda mostrano senza pudore i loro letti, con le rocce bianche e levigate e il fondo asciutto e sabbioso. Un fiume che riusciva a tenere un povero filo d’acqua anche nel torrido agosto,quasi a mantenere eternamente viva con quel filo la sua storia. Era l’Imera, il fiume che dava il nome alla città dove si combatté una battaglia decisiva tra Cartagine e Siracusa per il predominio sulla Sicilia.Era il settembre del 480 A.C., lo stesso mese e forse addirittura lo stesso giorno di un’altra grande battaglia tra oriente ed occidente, quella di Salamina. Agli storici antichi piacque pensare che questi due contemporanei trionfi sui barbari non fossero frutto di una coincidenza puramente temporale ma che l’unione che tutto il mondo greco seppe realizzare per la propria sopravvivenza, comprendesse anche la Sicilia greca. Oggi, ormai lontani e distaccati dalle esagerazioni patriottiche di Erodoto e Diodoro, possiamo solo affermare che le due battaglie, anche se solo contemporanee, si iscrivono a pieno titolo tra le vicende millenarie che hanno delimitato il mondo,e che, nelle nostre vicende minime, quella dell’Imera si iscrive tra le troppe contese che nel tempo hanno impedito alla Sicilia di sentirsi una.
All’oscuro della superbia del suffete Amilcare e della sua pietosa fine, ignara dell’astuzia di Gelone e dei suoi stratagemmi, Eugenia si assopì e dormì senza nemmeno accorgersi della successiva fermata del treno.
La svegliò una famigliola che irruppe nello scompartimento occupandolo rumorosamente, decisa ad impadronirsene. Erano in quattro: padre, madre e due figli, dei ragazzetti bruni e ricciuti. Questi ultimi si misero subito a litigare fra loro. Eugenia si preparò a difendere il suo spazio diventato piccolo ma per fortuna i ragazzi si stancarono presto e si addormentarono quasi nello stesso momento, come ubbidendo ad un comando tacito.
Eugenia li osservava sorridendo appena, quasi dentro di sé e sollevando lo sguardo incrociava il sorriso complice dei genitori,chiaramente orgogliosi di quei loro figli. Sembrava dicessero sì sono due diavoli, ci fanno tribolare ma sono anche tutta la nostra gioia. Nuovi pensieri le occuparono la mente: come sarebbe stata la sua nuova vita? Non ne aveva timore, provava solo curiosità e sentiva intensamente il desiderio di affrontarla nella pienezza delle sue forze. Quanto le veniva chiesto era molto difficile: l’aspettava una donna che si era ammalata di mente, le cui reazioni erano state e sarebbero state imprevedibili. Per volontà del marito non era stata ricoverata e sarebbe vissuta nella propria casa, sotto la sua vigilanza e la sua responsabilità.
Rifletteva su quella scelta. Ne aveva il marito valutato tutti i rischi? Lo aveva fatto per amore? Sapeva quanto questa scelta avrebbe influito e condizionato la sua vita e quella dei figli? E se fosse stata dettata da puro egoismo? Eugenia si riaddormentò e questa volta dormì a lungo,fino a quando, a Gerbini, scese dal treno e si dispose ad aspettare nella piccola e linda stazioncina il treno per Granfonte.
La linea ferroviaria per Granfonte era stata completata qualche anno prima e il primo treno era arrivato nel paese esattamente il 6 ottobre del 1907, accolto da squilli di tromba e discorsi aulici e reboanti. Sino ad allora il collegamento di Granfonte con il centro dell’isola e con Catania era stato affidato ad una società di servizio di diligenze che, si malignò, non era risultata estranea a certi ritardi altrimenti inesplicabili nel completamento dell’opera. Le diligenze si muovevano verso l’interno percorrendo le regie trazzere e, fino all’apertura della linea ferrata Palermo – Catania, lungo la rotabile Catania – Palermo.
La ferrovia ebbe un grande significato per Granfonte, facendone un piccolo crocevia e mitigandone l’isolamento feudale che durava da troppo tempo. Granfonte, come tutti i paesi etnei, era stata quasi interamente distrutto dal terremoto del 1693. Il 9 di gennaio, giorno in cui tutta la provincia, e non solo, “abballò senza sono”, come scrive un lepido e pittoresco ma non cinico cronista dell’epoca. Molti storici,assai più lontani nel tempo da quell’evento biblico, parlano con un pathos artificioso di “sopravvissuti sbalorditi e terrorizzati, che si reggono male in piedi, erranti incantati come fuori di sé affatto, senza più conoscenza di strade e di luoghi, dai quali era scomparso ogni segno”. Narrano di come attraverso le rovine “si vedevano corpi interrati affatto schiacciati; che di altri,coperti a mezzo dalla pietra spuntavano fuori o una mano,o un piede o il capo, e che qua e là, di sotto le macerie, s’udiva uscire fuori voci flebili e supplichevoli e gemiti e lamenti di semivivi”.
Tra questo semivivi ci fu un giovinetto di circa quindici anni, Leonardo Prospero, unico sopravvissuto tra le macerie del palazzo di famiglia sotto le quali avevano trovato la medesima morte i suoi familiari: il padre, barone di Sparacagna, la madre, Raimonda Vega Campagna, figlia del principe di Tudò, don Ignazio, altri congiunti, due fratelli e una sorella, tra cui il fratello primogenito. In breve, Leonardo Prospero, unico superstite della sua famiglia, ne divenne l’erede universale e diventò barone di Granfonte l’anno successivo.
La storia della ricostruzione delle zone terremotate in Sicilia non fu sempre uguale a quella che le cronache contemporanee ci consegnano per quelle avvenute ai nostri giorni. A volte la ricostruzione avvenne veramente, come fu nel caso del terremoto del 1693 che ha consegnato alla civiltà una grande città e splendidi paesini nel contorno. Un caso, un intreccio perverso di circostanze favorevoli tra capacità umane e interesse esterno?
L’aver forse il viceré Uzeda inviato da Palermo l’uomo giusto, a perenne ludibrio di quelli che si occuperanno dei successivi moderni cataclismi? A parlar male del dominio spagnolo in Sicilia a volte si corre il rischio di essere contraddetti dalla cronaca. Il 15 gennaio, dunque, ad appena sei giorni dal sisma, il viceré nominò il duca di Camastra e principe di Santo Stefano, Giuseppe Lanza Lucchesi, quale suo vicario, con l’incarico di dirigere la ricostruzione.
Il duca giunse a Catania il 4 febbraio successivo, non senza aver coscienziosamente visitato, durante il viaggio, tutti i paesi disastrati che si trovavano nel suo itinerario. Le cronache dell’epoca ci tramandano la figura di un uomo energico, che avviò con decisione ed efficienza la ricostruzione alla quale sovrintese fino al 1695
Ma qui ci interessa un altro grande protagonista della ricostruzione, per una vicenda legata alla nostra storia. Al vescovo Angelo Rosano, il vescovo di ferro, come fu soprannominato per il suo carattere forte, il temperamento energico e lo spirito di iniziativa, si deve la ricostruzione di innumerevoli edifici sacri e in particolare della cattedrale di Catania, per la cui ricostruzione versò di suo oltre centomila scudi. Carattere impossibile, si è detto, e l’uomo da questo suo carattere fu portato ad una eccessiva considerazione dei propri doveri e quindi dei diritti, veri e presunti che ne conseguivano e alla fine, inevitabilmente, a strafare.
Si narra che litigò col senato di Catania che negava il permesso di congiungere con un ponte a cavallo della strada di San Francesco, oggi dei Crociferi, il monastero con la chiesa di San Benedetto. Di notte Rosano fece iniziare la costruzione del cavalcavia e, per salvare l’architetto e i muratori che vi avevano lavorato, li sottrasse alla autorità laica conferendo loro gli ordini minori. Il fatto compiuto sconfisse il senato e l’opera fu portata a termine. Quanta nobiltà di intenti nelle origini dell’abusivismo edilizio!
Venne, alla buon’ora, ut amoveretur, nominato addirittura patriarca di Costantinopoli. Dieci anni dopo la sua morte, però, la sua salma fu traslata a Catania, in Cattedrale, nel mausoleo che protervamente vi si era fatto costruire. Chi ne volesse oggi ammirare il fiero cipiglio, percorra fino a metà la navata di destra della stessa Cattedrale.
Proprio nella residenza del vescovo Rosano avvenne l’incontro tra Leonardo e la sua futura sposa, pupilla del prelato. La storia non ci dice se l’incontro fu casuale,ma è certo che il matrimonio con Benedetta Serafini Valenza fu il risultato di una accorta e sperimentata strategia matrimoniale che le due famiglie avevano perseguito nel tempo. Allo stesso modo è certo che in forza di queste nuovissime nozze le due famiglie accrescevano enormemente il loro prestigio, la loro influenza e il loro potere economico e politico. Infatti da questa unione, per un complicato per noi ma chiarissimo a quei tempi, gioco araldico, a Leonardo ne veniva il titolo di Principe, cosa che sarà decisiva in una questione che il figlio di lui dovette affrontare dopo la sua morte.Il primogenito della coppia, principe Giuseppe, ereditò, tra l’altro, le rovine del paese d’origine della famiglia paterna, con l’onere fortemente condizionante ai fini della acquisizione di altre proprietà, oltre che sul piano affettivo, di ricostruire il paese che il padre non aveva dimenticato ma al quale, per gli onori e gli oneri connessi all’ascesa della sua potente famiglia, non aveva potuto dedicare il tempo che il suo affetto gli sollecitava.
Il giovane Giuseppe vide nel soddisfacimento della volontà del padre anche dell’altro: il luogo era in una posizione strategica,centrale rispetto al suo contesto territoriale e non tanto lontano rispetto all’intero patrimonio della famiglia da non potersi sperare che un’accorta politica non portasse, con successive acquisizioni, alla creazione di un unico patrimonio fondiario che da Acireale giungesse fino al confine con i paesi del Vallone.
Granfonte, però, era solo un cumulo di macerie completamente abbandonate. Ne era passato di tempo dal terremoto e i vicini che meno erano stati colpiti dal quell’evento, Baronie, Contee, Abbazie, Eremi e soprattutto i comuni demaniali, si erano fatti intraprendenti e si disponevano ad ostacolare con ogni mezzo il pericoloso, per loro, disegno del principe di ripopolare Granfonte, il cui territorio, dopo l’abbandono consideravano a mala pena un feudo.
(continua)
AVVISO AI NOSTRI LETTORI
Se ti è piaciuto questo articolo e ritieni il sito d'informazione InuoviVespri.it interessante, se vuoi puoi anche sostenerlo con una donazione. I InuoviVespri.it è un sito d'informazione indipendente che risponde soltato ai giornalisti che lo gestiscono. La nostra unica forza sta nei lettori che ci seguono e, possibilmente, che ci sostengono con il loro libero contributo.-La redazione
Effettua una donazione con paypal