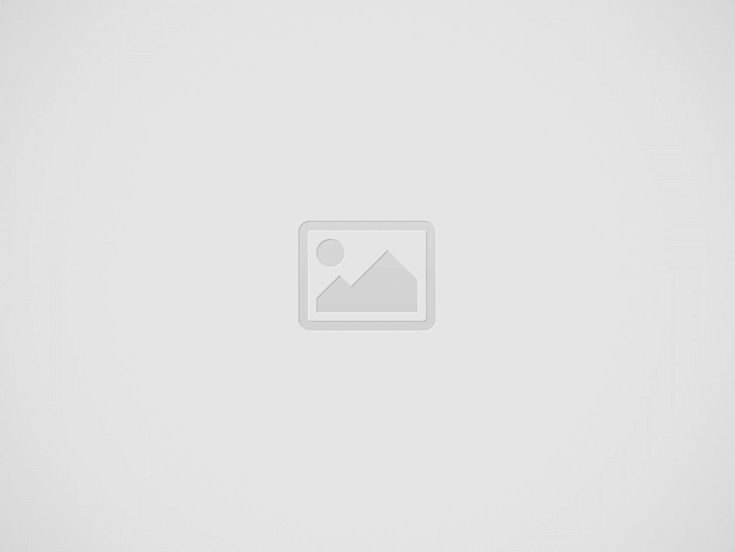

SIMBOLICA GIUSTIZIA AGENZIA BETTOLINI (Agenzia: DA RACHIVIO) (NomeArchivio: PAV-G1ig.JPG)
Chi riflette sulla questione con animo sgombro da pregiudizi di parte capisce bene che un sistema come il nostro si presenta come un groviglio inestricabile che non può essere sciolto, che deve essere reciso come il nodo di Gordio e sostituito con un altro. Ma a ciò osta una considerazione: se le cose stanno così non è per caso.
E’ chiaro che legalità vuole anche dire giustizia veloce. Non restare in attesa, per anni, di decisioni che possono cambiare del tutto il corso della propria vita. Perché magari, proprio mentre si aspetta la sentenza, la propria vita ha già preso un’altra strada, e quella decisione arriva troppo tardi.
“Il processo del lavoro fu riformato nel 1973 con l’obiettivo di renderlo celere, e con tempi certi: sessanta giorni per il lavoro privato, novanta per quello pubblico”, spiega Stefano Muggia, avvocato, “la realtà è molto diversa, ci vogliono anni per arrivare al giudizio. E questa lentezza, indipendentemente da ragioni e torti, colpisce sia il lavoratore sia l’impresa, rappresentando un costo materiale e morale”.
Attualmente sono più di un milione le cause di lavoro pendenti nei tribunali italiani. La durata media di un procedimento è di 1.530 giorni, pari a oltre quattro anni (con un periodo mediamente più lungo per il secondo grado di giudizio).
Umiliante, osserva Muggia, è il confronto con gli altri paesi europei: un processo per licenziamento in Italia dura in media 696 giorni (poco meno di due anni), a fronte di 19 giorni in Olanda, 80 in Spagna e 342 in Francia.
Sembra il catalogo di Leporello. L’ingolfamento, ovviamente, più che alle vere sue cause, viene attribuito alla cronica carenza di organici, e alla generale litigiosità degli italiani (E qui sta un paradosso. Siccome agli italiani piace l’opera, chiudiamo di teatri).
Qui potete leggere la prima parte